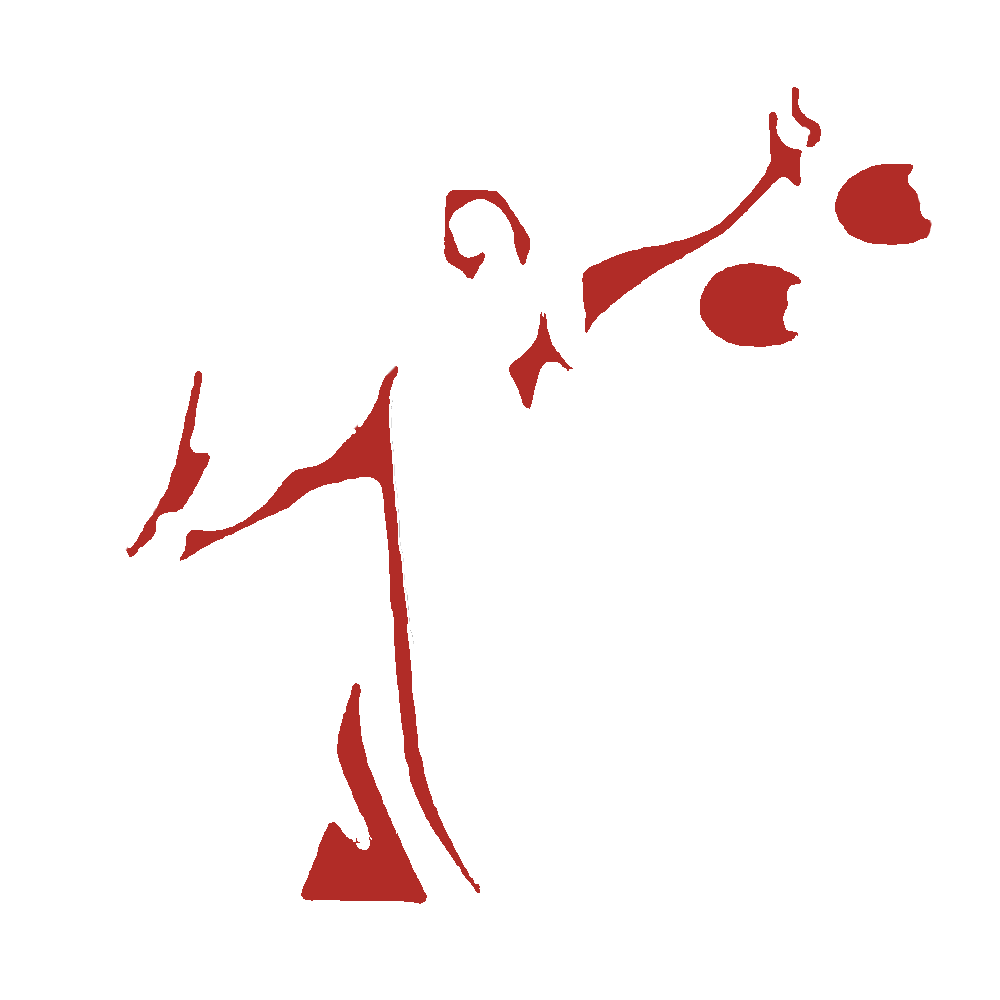Quando la contrattazione preliminare relativa alla compravendita immobiliare sia scandita in due fasi, con la previsione della stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già un preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero abbia soltanto effetti obbligatori con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Bari del 17 luglio 2020, n. 2252.
In effetti già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva osservato che è valida e produttiva di effetti la stipulazione di contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento), se sia configurabile un interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto fondata su una differenziazione di contenuti negoziali.
La violazione di tale accordo costituisce fonte di responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto (Cass. civ. sez. Unite, 6 marzo 2015, n. 4628).
La Suprema Corte, con la pronuncia or ora richiamata, era giunta al riconoscimento della piena validità di quegli accordi prodromici al contratto preliminare tradizionalmente inteso allorché sia rinvenibile in essi, secondo la preliminare valutazione del Giudice di merito, l’interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto ed alla differenziazione dei contenuti negoziali, e sempre che appaia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperto dal vincolo negoziale con essi originato.
Detti accordi, pertanto, ove ricorrano i presupposti appena citati, devono ritenersi contratti perfettamente validi, perseguenti interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico; contratti la cui violazione, contraria a buona fede, può dar luogo a responsabilità contrattuale da mancata stipulazione del contratto stipulando.
In altre parole, tale negozio è di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, (Cass. civ. sez. II, 19 novembre 2019, n. 30083; Cass. civ. sez. II, ord., 7 maggio 2020, n. 8638).
Non si tratta, in ogni caso, di affermare la validità del preliminare del preliminare già in via generalizzata, bensì avuto preciso riguardo alla causa concreta dell’operazione negoziale ove reputata meritevole dal giudice nel caso concreto. In altri termini, il “preliminare aperto” è valido – sottolinea la Suprema Corte – soltanto se «emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare».
L’indicazione di valide ragioni atte a giustificare l’accordo procedimentale si riverbera, come sottolinea la Corte, anche in ordine al regime di responsabilità in caso di violazione del preliminare del preliminare: infatti, il rifiuto di proseguire nel procedimento di formazione del contratto può legittimarsi soltanto dinanzi a una ragione conforme a buona fede. Ove ciò non sia, al contrario, la violazione del “preliminare aperto” darà luogo a una responsabilità contrattuale – poiché si tratta, in ogni caso, di accordi negoziali – la quale determinerà un risarcimento dell’interesse negativo, simile a quello risarcibile nel caso di responsabilità da rottura ingiustificata delle trattative.
Non ci si deve fermare, pertanto, all’alternativa “preliminare o definitivo“, perchè far ciò significa amputare le forme dell’autonomia privata, sia quando si vuole rintracciare ad ogni costo il contratto preliminare in qualunque accordo iniziale, sia quando si ravvisa nel c.d. preliminare chiuso il contratto definitivo, passibile soltanto di riproduzione notarile.
Spetterà all’interprete vagliare caso per caso l’emergere dell’interesse delle parti e verificare, soprattutto nelle contrattazioni immobiliari, se la proposta irrevocabile contenga gli elementi del contratto preliminare o se costituisca una mera puntazione delle trattative, perché le parti hanno omesso di verificare – e lo faranno solo in sede di preliminare – alcuni elementi essenziali del negozio.
Sul punto, di recente, la Corte di Cassazione (sez. II sentenza n. 26484 del 17 ottobre 2019 ha affermato che: «La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda soltanto effetti obbligatori (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disvalore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla base dell’operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale» (v. anche Cass. civ. sez. II, ord., 28 novembre 2019, n. 31188).